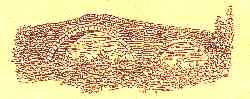
Giuseppe Cassinelli e Dolcedo
Il Tresto nel cuore
di ORIETTA MAZZOCCO BUT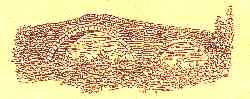
E’ uno strano paese Dolcedo: già il nome t’incanta e il greto roccioso del Prino, la palazzata, i mulini, la chiesa di San Tommaso col suo chiuso sagrato, il ponte grande sono scenari affascinanti, fondali avvolti nel silenzio. Sembra che il tempo si sia fermato e un incantesimo abbia bloccato la vita: è la sensazione che danno un po’ tutti i paesi dell’entroterra ponentino, ma che qui si avverte in modo particolare. Vuoto o quasi da chi lo ha nei secoli modellato ed animato, il paese ospita ora presenze che portano con sé umori e consuetudini di altre terre, di altre civiltà. Il senso di straniamento che si avverte, davvero un po’ angosciante, ti mette in uno stato d’animo di attesa.
Leggi l’ultimo lavoro di Giuseppe Cassinelli, qui nato e vissuto per molti anni, e Dolcedo torna ad animarsi, la vita di circa un secolo fa irrompe nei carruggi, risuonano le voci, si intrecciano i dialoghi; la siccità ormai annosa occupa le menti e la paura dell’avvenire genera mostri: il Tresto, “un coso grosso e scuro che si allontanava svelto come una faina”, con un “ansare come di animale” e lamenti e strepito metallico.
Con un’operazione linguistica di grande difficoltà ed impegno Cassinelli ricostruisce le strutture dialettali con le quali far parlare i personaggi. A raccontare non è il narratore, la voce che racconta è interna al mondo rappresentato sicché la struttura del linguaggio è elementare, punteggiata di modi di dire,proverbi, termini dialettali, se ad esprimersi sono i popolani, più complessa se a parlare è un membro del casato dei Mainardi o dei Raineri, la nobiltà terriera.
La tecnica narrativa verista richiede capacità di immergersi nella realtà e di eclissarsi, escludersi: niente riflessioni, considerazioni squarci descrittivi; tutto deve essere costruito dai personaggi e visto attraverso i loro occhi. Ci si può chiedere il motivo di questa scelta così difficile e severa, così diversa dalla lingua poetica che conosciamo dalle raccolte in dialetto e in lingua. Il risultato è un’aderenza alla realtà altrimenti impossibile; ne esce la ricostruzione di un’epoca di profonda crisi economica e sociale, di un mondo angusto, dominato da regole destinate a far soffrire non solo gli oppressi, gli sfruttati, ma anche la classe dominante, l’aristocrazia terriera dei “casati”, delle “zende” ormai sulla via dell’estinzione.
La vicenda si svolge all’incirca negli anni in cui Boine pubblica sulla Voce “La crisi degli ulivi in Liguria” (6 luglio 1911), individuando fra le cause anche la ormai decennale siccità. Ritroviamo in Cassinelli, che di Boine è conterraneo e studioso fra i più rappresentativi, i temi della crisi della olivicoltura e della denuncia dell’angustia intellettuale e morale presenti ne “Il peccato” e in altri scritti.
Fra gli innumerevoli personaggi che percorrono le mulattiere e i carruggi di Dolcedo, ciascuno con il suo soprannome, secondo l’uso ponentino, Tunù il Marcianese e lo Storto rappresentano due estremi. Tunù si muove alla perenne ricerca di compaesani con cui commentare i fatti del borgo che conosce nelle pieghe più segrete; egli blatera sulle abitudini dei signori e degli “scarpegrosse”, mettendo a fuoco una complessa trama di rapporti interpersonali e l’intrecciarsi dei giudizi e dei commenti sulle vicende: un coro di voci. Dalle sue parole e da quelle di altri lavoranti emerge una critica disincantata sui Mainardi ed in particolare sul rifiuto che il capofamiglia Filippo aveva opposto alla richiesta del Maestrino innamorato di Nuccia: le regole del casato escludevano la possibilità di relazioni parentali con chi veniva dal basso, anche se meritevole. Contemporaneamente, però, suscitava allusioni sarcastiche il matrimonio contro le regole tra Bandò, ricco negoziante, e madama Pradarola. Segno che le divisioni sociali sono considerate naturali e scandaloso violarle. Nicuccio Orengo, fra i più ricchi del paese, proprietario di palazzi, non osa salutare scià Lisetta, la bella figlia del sciù Daneri, e nemmeno porgerle l’acqua benedetta quando entra in chiesa, perché “ha il casato”.
Come è evidente siamo di fronte ad una rappresentazione corale da cui emerge un mondo fatto di miseria e fatica, “questa che mai non passa, umana fatica”, rigide ed invalicabili divisioni sociali, pregiudizi e paure aggravate dalla persistente siccità che toglie vigore alle piante ed agli uomini e non lascia intuire speranza di cambiamento. Il caldo induce la gente a dormire all’aperto, su pagliericci stesi per terra, anche se è solo aprile. “Strano aprile, come una tarda estate, più simile al declino che al fiorire dell’anno”. Si rinnovano i riti della Pasqua, ma la religione appare un simulacro vuoto. Solo due personaggi hanno un senso religioso, pur se tormentato, della vita, proprio i due che menano scandalo, che vanno, a dirla con De André, “in direzione ostinata e contraria”, lo Storto e Lorenzo Mainardi, l’eremita ed il pittore.
Lorenzo Mainardi, tornato dopo un’assenza di dieci anni, ritrova il fratello angustiato dalla crisi economica, sempre più aggrappato alle rigide convenzioni sociali come fossero capaci di impedire il franare di quel mondo e le sorelle, in quanto “donne di rango” condannate ad una vita di rinunce e solitudine, ma ancora spiritualmente vive, soprattutto Nuccia.
Lorenzo è un animo tormentato che solo nell’arte trova conforto, ma anche l’arte suscita scandalo quando sant’Antonio prende il volto dello Storto.
Lo Storto, “una specie di eremitto”, è socialmente un emarginato,in realtà un saggio che dal mondo si è distaccato, che vive in solitudine con una capra in cima alla collina, figura enigmatica che concentra in sé una fortissima spiritualità, fatta di ricerca dell’essenziale attraverso la rinuncia a tutto ciò che può suscitare reazioni emotive (per stanare il Tresto che sempre si annida in fondo al cuore bisogna “fare pace e silenzio nei pensieri”), e nello stesso tempo una quasi superstiziosa paura che il ritratto sia un furto dell’anima. Lo Storto ha in sé un po’ del Santo di Boine? Quando Lorenzo parla alla sorella Nuccia dello Storto dicendo che se esistesse un uomo capace di incarnare ciò che il suo occhio azzurro esprime, basterebbe a riscattare l’intera umanità, a giustificarla, pensiamo a Boine che ne “La città”, comparso come primo contributo alla collaborazione con la Riviera ligure, presenta la figura del Santo, il prete “un po’ curvo, dall’occhio cilestro, arguto”, una figura che per Boine era l’anima della città, lo spirito vivificatore che la salva dalla rovina incombente.
Ma anche la figura del Maestrino assume una forte valenza religiosa quando di lui un giovane, che lo ammira, cita i versi dedicati al girasole che “anche nei foschi giorni / ruota la sua corona / da levante a ponente. / Il sole non si vede, / ma il girasole, ch’è / del sole innamorato, / lo sa che c’è. Lo sente.”, scritti per coloro che negano l’esistenza di Dio solo perché non si offre alla nostra esperienza sensibile. I versi sono la traduzione di una poesia in dialetto “Miàmu u gìasù contenuta nella raccolta “U fieu e a neutte”, dal che si deduce che il Maestrino altri non è che Cassinelli, il quale a Dolcedo trascorse l’adolescenza e parte della giovinezza, sperimentando di persona la secolare arretratezza e la chiusura di un mondo arroccato nei suoi pregiudizi e nelle sue superstizioni, nei riti formali destinati a tenere ben separate le classi.
A I lunghi giorni del Tresto seguono due racconti brevi, “Il tesoro di Fiorinda” e “ Tunù e il lupo”, sempre nello stile verista scelto per raccontare storie vere. Fiorinda l’ho conosciuta, è morta due anni fa ultracentenaria, e anche a me ha raccontato questa ed altre storie di quand’era “garsunetta”e pascolava le pecore sui monti di Triora. Raccontava vicino alla sua casa, seduta “lungo il muraglione secentesco che cerchia la piazzetta” non dei Mainardi, come nel romanzo, ma del Palazzo, a Torrazza, dove Cassinelli trascorre con la famiglia l’estate.
“Tunù e il lupo”, con un’inaspettata conclusione di sapore francescano, era originariamente scritto nel dialetto di Dolcedo. Come si vede dialetto e narrazione verista, che permette di modulare la lingua in strutture dialettali, si scambiano come avviene nelle poesie che mantengono la loro carica lirica nella versione originale in dialetto come nella traduzione. L’uso di termini dialettali comporta la presenza a fine romanzo di una pagina di glossario come avviene nelle edizioni di Francesco Biamonti. E’ un aspetto che accomuna Biamonti a Cassinelli questo della cura estrema del senso della parola impreziosita di risonanze dialettali. Il lavoro di lima per eliminare ogni impressione di intervento soggettivo del narratore ha dato frutti eccellenti: un mondo è stato riportato alla vita, non un mondo da rimpiangere, ma salvato alla memoria. Cassinelli ha lasciato in questo suo ultimo lavoro i versi per la prosa, ma, come è stato scritto in un’intervista del 1999, “In realtà egli è poeta anche qui. La parola scritta – di una poesia o di un racconto in prosa – per lui è sempre molto di più della comunicazione corrente: è il mezzo dell’espressione, ma è anche l’anima di ciò che si intende esprimere”.
Orietta Mazzocco But
2004 Le Mani – Microart’s Edizioni Genova € 12.50
Per informazioni scrivi a: webmaster@torrazza.it |